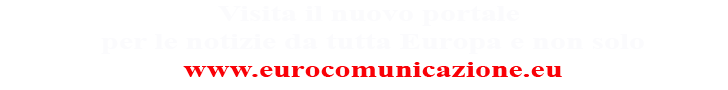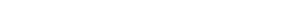Intervista a Michèle Favorite, docente di Comunicazione aziendale alla John Cabot University di Roma: «Servono ponti col mondo del lavoro»
L’università italiana fornisce le chiavi giuste per trovare un posto di lavoro oggi? Quanto prontamente gli atenei rispondono ai cambiamenti repentini e continui del mondo occupazionale? Perché le matricole e i laureati stanno diminuendo? Quali sono le competenze richieste dalle imprese ora, e da qui a 5 anni? Per rispondere a queste domande la John Cabot University (JCU), fra le più grandi università americane d’Europa, con sede nel cuore di Roma, a Trastevere, lo scorso 14 luglio ha organizzato una conferenza fra manager, docenti e rappresentanti di organizzazioni internazionali di studenti.
 È stata Michèle Favorite, docente di Comunicazione aziendale della JCU, a innescare la miccia, ponendo un quesito provocatorio – titolo del confronto – che ha generato un dibattito ampissimo, diventato ormai virale: serve ancora l’università per trovare lavoro?
È stata Michèle Favorite, docente di Comunicazione aziendale della JCU, a innescare la miccia, ponendo un quesito provocatorio – titolo del confronto – che ha generato un dibattito ampissimo, diventato ormai virale: serve ancora l’università per trovare lavoro?
Spiega la professoressa Favorite: «La percentuale di laureati in Italia è la più bassa d’Europa e il tasso di abbandono è tra i peggiori. Se a ciò aggiungiamo il tasso Ue più alto di NEET (o né-né, cioè persone non impegnate nello studio, né nel lavoro e né nella formazione), e l’aumento di ragazzi che si spostano all’estero, la prospettiva che si profila è quella delle “generazioni fantasma”, quindi di giovani che avranno scarso peso nella creazione di valore per il nostro Paese. Dobbiamo allora chiederci: cosa deve fare l’Università per attrarre più studenti?».
Il sistema universitario deve aggiornarsi?
«Guardiamo la realtà. I nostri giovani devono confrontarsi con un mondo occupazionale in continua e velocissima evoluzione. Ciò che è richiesto oggi, potrà rivelarsi anacronistico fra nemmeno cinque anni. Non è un modo di dire. Di conseguenza le università, per arginare l’emorragia di matricole – di cui troppo poco se ne parla – e riprendere ad attrarre studenti, devono gettare ponti col mondo del lavoro. Quando parlo di ponti non sto facendo una metafora, mi riferisco a collegamenti veri, concreti, tangibili».
 Adesso chi se lo può permettere va all’estero.
Adesso chi se lo può permettere va all’estero.
«Proprio così. Se le iscrizioni presso le università sono in calo e chi ha la possibilità si trasferisce in altri Paesi per studiare e lavorare, e non torna più, significa che stanno diminuendo le persone che, a vario titolo e nei vari livelli istituzionali, un domani potranno creare e produrre per il nostro Paese, o esercitare una leadership; allora la questione che dobbiamo porci è: chi creerà ricchezza in futuro per l’Italia? Bisogna agire, e in fretta, per invertire la tendenza. Gli ultimissimi dati sono veramente brutti».
A quali ultimissimi dati si riferisce?
«Nel corso della conferenza che abbiamo organizzato alla JCU, il presidente Aiesec (la più grande organizzazione internazionale interamente gestita da studenti) Roma Tre, ha presentato un’anteprima dei dati italiani, estrapolata da un sondaggio appena concluso su oltre 160mila giovani di tutto il mondo. Ebbene, avere uno scopo nella vita, per i ragazzi del nostro Paese non è una priorità: è stato infatti inserito al 7° posto per importanza. Al primo c’è la “curiosità”. La curiosità è un termine generico per dire tutto e nulla, a testimonianza di una confusione probabilmente imperante fra tanti giovani. Vale la pena evidenziare che, nel resto del mondo, la famiglia è in cima alla lista e subito dopo c’è lo scopo, cioè la visione del futuro. E proprio alla domanda “come vedete la società futura?”, globalmente i giovani hanno risposto “migliore” nel 68% dei casi; in Italia, invece, uno su due ritiene che sarà peggiore».
 Un quadro disarmante.
Un quadro disarmante.
«Tutti gli indicatori sono concordi nel definire le criticità dello scenario attuale. Un tempo si diceva “prima pensa a studiare, poi un lavoro si troverà”. Ora non funziona più. Oggi i giovani devono affrontare un mercato globalizzato in rapidissima trasformazione. Le aziende, giorno per giorno, riallineano le proprie strategie per rimanere sul mercato. Un ragazzo magari ha in mente una professione, ma non sa che non c’è più. Di contro, l’università appare statica, una specie di grande parcheggio, invece di rappresentare un ponte verso la professione desiderata. In Italia l’età media di chi cerca il primo impiego è troppo alta: 25-27 anni, rispetto ai 22 del resto d’Europa. È indispensabile portare il mondo che cambia nell’università».
 Il modello tradizionale accademico segna il passo?
Il modello tradizionale accademico segna il passo?
«La funzione dell’università deve essere quella di far raggiungere il lavoro, non il pezzo di carta che si chiama laurea. Dirò di più, entrando nel merito: è fondamentale studiare e, allo stesso tempo, acquisire esperienze professionali, anche senza gratificazioni economiche immediate. Affidarsi a quanto appreso e certificato da un diploma, senza aver fatto esperienze sul campo, sicuramente non basta, soprattutto in tempo di recessione».
È fondamentale portare le aziende nelle aule di studio?
«Il mio modello di riferimento è quello anglosassone, pratico e concreto. In questo senso faccio l’esempio della realtà in cui sono impegnata: la John Cabot, attraverso uno specifico “Centro per i servizi alla carriera”, mette in collegamento gli studenti con oltre 400 fra aziende e istituzioni. Il 90% dei colloqui dei nostri ragazzi si risolve con successo e l’84% degli stage si conclude con un posto di lavoro».
 Quali sono i profili ricercati in questo momento?
Quali sono i profili ricercati in questo momento?
«Le aziende assumono persone flessibili, dotate delle cosiddette soft skills, cioè di abilità comportamentali. Persone, quindi, che sappiano impegnarsi nella logica di team, sulla base di esperienze di stage, compiute durante il periodo universitario, presso imprese e istituzioni. Il solista non lo vuole più nessuno. Le chiavi di volta per accedere alla realtà occupazionale si chiamano problem solving, orientamento al risultato, visione strategica, time management, public speaking, leadership. Soft skills, appunto. L’università deve aiutare ad acquisire anche queste competenze, definite morbide, al contrario di quelle hard, inerenti la formazione accademica propriamente detta».
Leonida Valeri
Foto © JCU