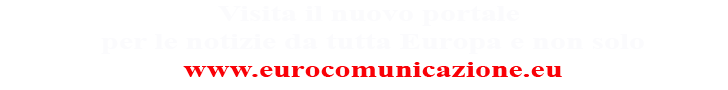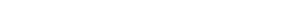La cortina di ferro è calata sull’Ucraina, teatro di una crisi che si può risolvere solo con un sano pragmatismo
Dopo mesi di guerra e di morte, il conflitto in Ucraina sta svoltando verso la sua più prevedibile conclusione: diventare il simbolo della Seconda Guerra Fredda. Nell’ultima settimana, ha cominciato a delinearsi uno scenario che sembra una sorta di Yalta 2.0, dalla quale emergono una nuova cortina di ferro calata sull’Europa e due blocchi che stanno cominciando, per usare un termine tecnico, a “cristallizzarsi”.
Tutto parte da un dato ormai certo: la capitolazione delle repubbliche secessioniste di Donetsk e Lugansk, che sembrava ormai imminente ad inizio di agosto, non solo non è avvenuta grazie ad un aiuto militare di Mosca, ma ora sono le stesse armate di Kiev ad essere in difficoltà, tanto che Vladimir Putin ha chiesto ai miliziani secessionisti di aprire un corridoio umanitario per consentire ai soldati ucraini di ripiegare.
Il precipitare della situazione ha spinto il presidente ucraino Petro Poroshenko a chiedere, in modo più insistente che in passato, che il suo Paese venga subito ammesso nella Nato, ma la linea dell’Alleanza Atlantica, espressa dal segretario generale Rasmussen, è solo quella di militarizzare il confine Est, quello che va dalle repubbliche baltiche fino alla Bulgaria, contro la minaccia militare russa. Una linea del non intervento diretto, sposata da Barack Obama (colpire con le sanzioni, non con le armi) e dall’Unione Europea (nessun sostegno militare a Kiev, solo ritorsioni economiche contro Mosca): sia Washington che Bruxelles sanno bene quanto sia impensabile una guerra alla Russia per mantenere in Ucraina delle regioni che ucraine non si sentono affatto.
Dunque, la realpolitik sta prendendo il sopravvento nelle decisioni dei policy makers. In modo defilato, ma ciò sta avvenendo. L’azione più diretta dei russi nella crisi sembra ormai reso evidente che l’Est dell’Ucraina non rientrerà tanto facilmente sotto il controllo di Kiev, ora che i secessionisti sanno di avere le spalle protette da Mosca: la loro stessa presenza al Tavolo delle trattative, e il loro porre le condizioni per la pace (che in sostanza ruotano intorno al ripristino delle autonomie revocate alla caduta di Yanukovic, a cominciare dal russo come lingua ufficiale) rappresenta la loro stessa evoluzione ad un ruolo governativo, a cui Kiev è costretta a dar credito accettandone la presenza nel Gruppo di Contatto con Osce e Russia.
C’è poi il nuovo ruolo di Putin nella vicenda: dapprima defilato, negli ultimi tempi il presidente russo sta intervenendo sempre più spesso in prima persona sul conflitto, quasi a “segnare il territorio”. E’ probabile che il Cremlino, attraverso la negoziazione in prima persona del futuro dei “fratelli” russofoni d’Ucraina, abbia ora indossato gli abiti del padrino dei popoli d’idioma russo: quello che ieri era il Comintern attraverso l’ideologia comunista, domani potrebbe riproporsi attraverso una nuova “fratellanza” internazionale nel nome della lingua russa, che nello spazio ex sovietico non è parlata solo da russi e ucraini.
La crisi nel Sudest dell’Ucraina sta intanto assumendo i contorni di quella del 2008 tra la Russia e la Georgia, quando oggetto del contendere erano le repubbliche russofone di Abkhazia e Ossezia del Sud, che nell’agosto di quell’anno furono attaccate dai soldati di Tbilisi a cui Mosca rispose con un intervento militare che sfociò nell’invasione della Georgia stessa. Anche allora l’Occidente protestò vibratamente contro l’azione russa, ma non ritenne opportuno deteriorare i propri rapporti con Mosca per due lembi di territorio caucasico: tutto si concluse con la proclamazione dell’indipendenza delle due repubbliche, riconosciute però solo da una manciata di Stati.
Oggi lo scenario ucraino potrebbe essere identico, con un’analoga soluzione: se i colloqui in corso a Minsk dovessero risolversi in un nulla di fatto e Donetsk e Lugansk dovessero proclamare la secessione, questa di certo non sarebbe riconosciuta da Usa e Ue, ma verrebbe accettata nel nome di un sano pragmatismo, come unica via per fermare una pericolosa escalation militare e i suoi contraccolpi economici.
Un modus operandi che tra l’altro non è nemmeno inedito: pochi mesi prima del suo famoso Ich bin ein Berliner, Kennedy, che non aveva alcuna intenzione di fare una guerra a difesa di Berlino Ovest, commentò la notizia che i sovietici e i tedeschi della DDR avevano isolato Berlino Est con la costruzione del Muro con un laconico “non è la miglior soluzione, ma comunque una soluzione per evitare una guerra nucleare contro l’Urss”.
La realpolitik può rivelarsi cinica, ma talvolta anche utile.
Alessandro Ronga
Foto © The White House, 2013